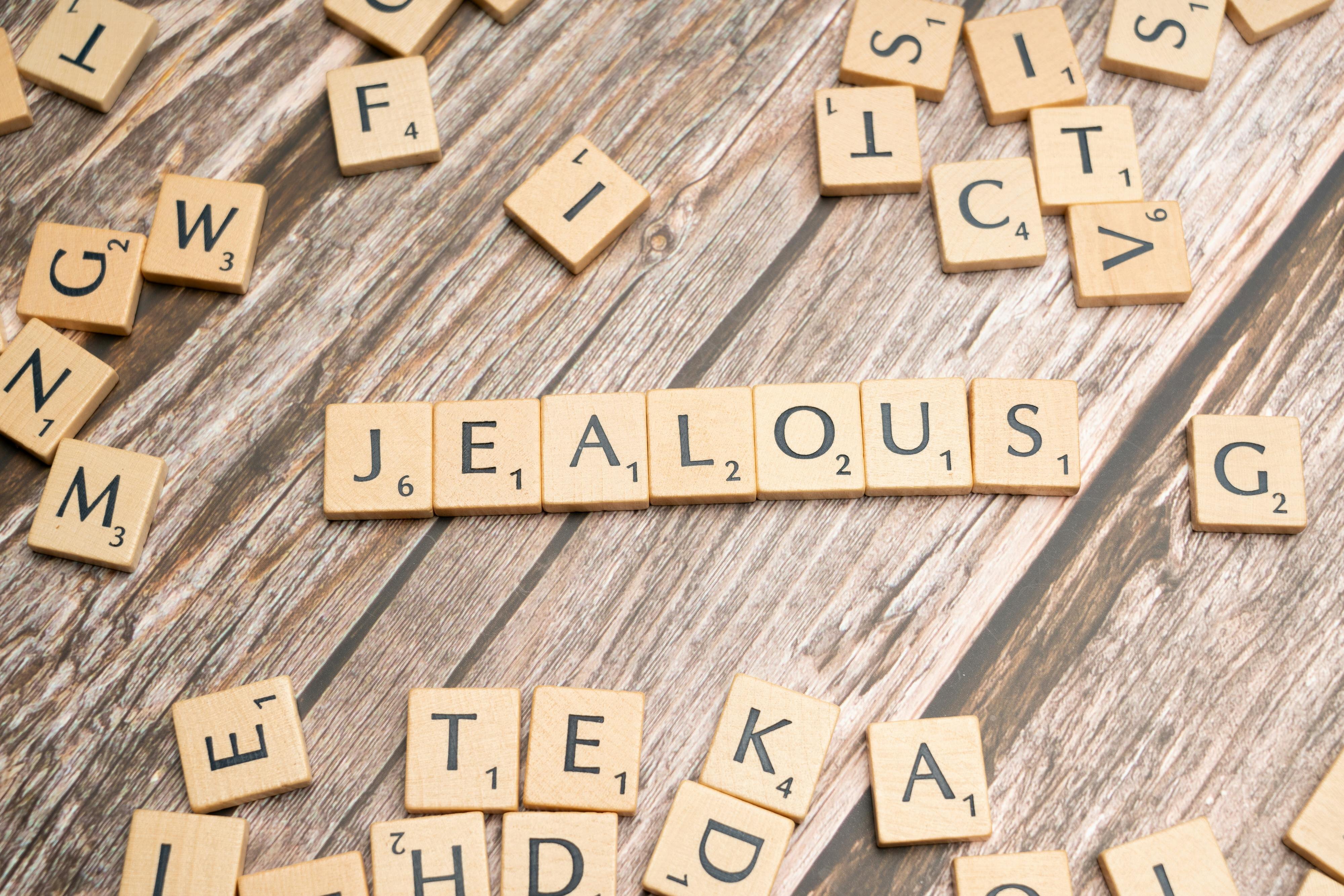La gelosia è un’emozione complessa che nasce dalla paura di perdere ciò che ci appartiene. Secondo Charles Darwin è un’emozione che ha una precisa funzione evoluzionistica: proteggere la coppia al fine di garantire la continuità della specie attraverso la riproduzione e l’accudimento congiunto della prole. La gelosia evoca risposte somatiche, cognitive e comportamentali e può manifestarsi all’interno di una qualsiasi relazione diadica in cui un terzo può minacciare il mantenimento di un dato legame reputato come significativo.
Secondo la psicoanalisi le esperienze infantili con i fratelli o con altre figure ritenute rivali influenzerebbero la nascita di modelli di gelosia che vengono poi mantenuti in età adulta.
Alcuni studi suggeriscono che in ogni bambino esista a livello temperamentale un certo grado di sensibilità verso la perdita dell’esclusività nelle relazioni che fa percepire più o meno forte il senso della minaccia. Già prima dell’anno di vita sembrano presenti nel piccolo precursori della gelosia, sentimento che tenderebbe a presentarsi in una forma più strutturata non prima dei 15-24 mesi, periodo in cui i bambini raggiungono un certo grado di comprensione delle relazioni interpersonali.
La gelosia il cui oggetto della paura è il partner, di cui temiamo di perdere l’amore, l’affetto, l’attenzione o il possesso, è definita gelosia romantica. Questo tipo di gelosia si associa alla percezione, reale o presunta, che un rivale possa minacciare l’esclusività di una relazione. La gelosia romantica scatena una serie di vissuti tipici ma differenti, tra cui la tristezza, la paura della perdita, la rabbia, la collera, l’umiliazione, l’insicurezza, etc. A livello comportamentale l’intensità e la varietà delle reazioni possono essere molteplici e vanno dall’evitamento, al mettere in atto forme sottili di aggressione, e nel peggiore dei casi, a veri e propri tentativi di controllo del partner, fino all’intimidazione e all’aggressione vera e propria. Se il sentimento di gelosia è circoscritto a brevi momenti e ha per oggetto un evento specifico è tipicamente definita come un’emozione complessa; se connota una disposizione della persona, questa non si manifesta necessariamente in relazione ad un evento specifico ma più stabilmente nel tempo indipendentemente dagli eventi.
La normale aspettativa di ogni individuo è quella di essere l’oggetto di amore di una persona, di potersi sentire al sicuro in una relazione affettiva in modo da ricevere sostegno e cura; il desiderio che ne deriva è che la relazione che conforta non venga mai minacciata. Ma se questo desiderio si trasforma in paura dell'abbandono, se interferisce con il benessere della persona, se invade i pensieri, diviene allora un qualcosa che può allontanare sia dall’amore che dalla libertà. La paura di perdere l’oggetto d’amore affonda le proprie radici nella storia di vita dell’individuo, trova terreno fertile nell’insicurezza e nella sfiducia e può appannare le lenti attraverso le quali si guarda il presente. Se la gelosia prende il sopravvento, se la paura dell'abbandono diventa una forte preoccupazione, chiedere aiuto è il primo passo per venirne a capo ed evitare agiti che possano danneggiare irreparabilmente la propria relazione, sé stessi e il partner.
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali nella sua quinta edizione (DSM-5), contempla due forme di gelosia patologica: la gelosia delirante e la gelosia ossessiva. La prima è caratterizzata da una convinzione delirante di infedeltà, la seconda dall’impossibilità di mettere a tacere il dubbio circa l’infedeltà del partner. La gelosia delirante e la gelosia ossessiva sono riscontrabili rispettivamente nel Disturbo Delirante e nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo quando il contenuto delle convinzioni deliranti e delle ossessioni assuma queste forme. In altri disturbi mentali manifestazioni disfunzionali della gelosia possono essere osservate come risposte secondarie.
La gelosia rappresenta un’emozione fisiologica della vita affettiva dell’individuo fino a quando questa non attivi fragilità e vulnerabilità personali che, in concomitanza con altri fattori, possono avviare processi che conducono agli scenari più disparati.
Autore: Mirella Baldi
RIFERIMENTI
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5. Arlington, VA. (Tr. It. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione, DSM-5. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014).
D’Urso, V. (1995). Otello e la mela: psicologia della gelosia e dell’invidia. NIS:
De Steno, D. A. (2004). New perspectives on jealousy: An integrative view of the most social of social emotions. Paper presented at the meeting of the American Psychological Society, Chicago.
Dijkstra, P., Barelds, D.P.H., e Groothof, H.A.K., (2010). An inventory and update of Jealousy-evoking partner behaviours in modern society. Clinical Psychology and Psychoterapy, 17, 329-345.
Geary, D.C., Ramsey, M., Bow-Thomas, C.C., Hoard, M.K. (1995). Sexual jealousy as a facultative trait: Evidence from the pattern of sex differences in adults from China and the United States. Ethology and Sociobiology, 16, 355-383.
Hart, S. L., e Carrington, H. (2002). Jealousy in 6-month-old infants. Infancy, 3, 395- 402.
La Moglie, A., Crisi della coppia: natura e cultura della relazione amorosa, Edizioni Borla s.r.l, Roma, 2001.
Lewis, M. (2003). The development of self-consciousness. In J. Roessler e N. Eilan (Eds.), Agency and self-awareness (pp. 275-295). Oxford: Clarendon Press.
Pines, A.M., e Friedman, A. (1998). Gender Differences in Romantic Jealousy. Journal of Social Psychology, 138(1), 54-71.
Wallon, H. (1970). L’origine del carattere nel bambino. Roma: Editori Riuniti, 1974.
White, G. L., e Mullen, P. E. (1989). Jealousy: Theory, research and clinical strategies. New York: Guilford Press.
Zammuner, V.L., Zorzi, C. (2012). Gelosia, amore e violenza: le credenze circa la gelosia maschile e le loro implicazioni. Psicologia Sociale, 1, 121-147